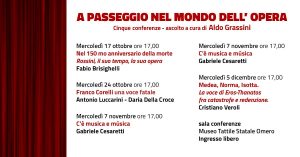Una lunga chiacchierata con una persona a molti di voi sconosciuta, che per la sua costanza e dedizione, ma soprattutto per i risultati che ha raggiunto, illumina la nostra categoria di Persone con disabilità visiva. Persa la vista a 13 anni, imperterrito continua a perseguire i suoi obiettivi. I genitori hanno sempre creduto in lui, lo hanno sempre incoraggiato a rapportarsi e confrontarsi con il mondo.
A ogni mia domanda, il Prof. Massimo Morelli risponde con tranquillità e professionalità, riflettendo sempre prima di parlare. Voce importante, serena; soprattutto delinea una personalità consapevole, sicura di se, delle sue possibilità e dei suoi limiti.
Da “La voce d’Italia ” (2015), giornale italiano di New York, estrapolo un concetto importante da una intervista al Prof. Morelli:
“Fondamentale è il rispetto delle regole, avere la reale sensazione che nessuno possa superarti se non ne ha i meriti. Non devono esistere domande di carattere personale né pregiudizi. Dobbiamo essere giudicati solo per le nostre capacità e meriti. Quindi, se si ha un handicap, non devi essere discriminato, solo così si possono avere possibilità di crescere e dimostrare il proprio valore”.
Link: https://voce.com.ve/2015/07/02/119241/morelli-meritocrazia-e-rispetto-delle-regole-queste-le-grandi-differenze/
Massimo Morelli
Docente Professore Ordinario, Dipartimento di Scienze sociali e politiche, Università Bocconi Milano.
Note biografiche
Degree in Economics and Social Sciences (summa cum laude) all’Università Bocconi University nel 1991. Relatore Professore Mario Monti;
Dottorato in Economia Politica all’Università di Pavia, 1995;
Ph.D. in Economics Harvard University, 1996.
Curriculum Accademico
Professor of Political Science, Bocconi University, since 2014;
Professor of Political Science and Economics, Columbia University, since 2007;
Fellow Innocenzo Gasparini Institute for Economic Research (IGIER);
Research Associate National Bureau of Economic Research; Visitor Einaudi Institute for Economics and Finance;
Part-time Professor of Economics at the European University Institute, 2009-11;
Associate Professor of Economics and Political Science at the Ohio State University (2004-07).
Aree di interesse scientifico
Game theory, mechanism design, political economy, governance institutions, development economics, behavioral and public economics, comparative politics and international relations.
Link: https://www.sdabocconi.it/it/faculty/morelli-massimo
Bene iniziamo, mettetevi comodi, due chiacchiere con “il Professore”.
V: Tra i nostri lettori ci sono tanti ipovedenti e non vedenti. Prof. Morelli, può descriversi affinché possano farsi un’immagine della sua persona.
M: Ho 53 anni, compiuti il 18 settembre, sono alto 2,11 m. Sono affetto dalla sindrome di Marfan, una malattia genetica che colpisce il tessuto connettivo, con evidente gigantismo, abbastanza robusto. Sono completamente pelato, alcune mie foto mi riportano con i capelli, ma ultimamente li ho persi tutti. Diversamente non ho altri segni particolari da evidenziare.
V: Professore ci può spiegare di cosa si occupa in questi giorni e qual è il suo compito in questa prestigiosa Università Italiana?
M: Sono Professore Ordinario nel Triennio e in un Master. Nel corso della triennale, insegno materie come Relazioni Internazionali, con tematiche riguardanti la teoria dei conflitti, come emergono i conflitti civili interstatali, come si possono razionalizzare purtroppo fenomeni storici come il genocidio, spiegare l’uso della violenza nella storia e nel presente, risoluzione dei conflitti, potenziamento della pratica della mediazione tra parti in conflitto, mentre la parte finale del corso riguarda le relazioni internazionali più “pacifiche”, la costruzione dell’Unione Europea, così come l’unione fiscale e l’unione politica, il funzionamento dell’Unione Europea. L’ultimo tema del corso affronto la tematica, molto attuale, come le migrazioni dei popoli.
Nel corso di Master invece insegno la teoria dei giochi per capire non solo le problematiche conflittuali ma anche capire la partecipazione strategica al voto. Il comportamento strategico dei burocrati nei loro comitati decisionali e il comportamento dei burocrati, all’interno della struttura di uno Stato. Ci sono dei comportamenti non solo dettati dalle preferenze di voto, esiste sempre il modo per applicare la teoria dei giochi. Attualmente il tema di ricerca che va per la maggiore, tra noi economisti politici è “il populismo”; Il populismo è un atteggiamento culturale politico che risalta genericamente il popolo, sulla base di un forte sospetto nei confronti della democrazia rappresentativa. Studiamo come si arriva ad avere nelle democrazie una crescita del populismo sia da destra che da sinistra, quali potrebbero essere le conseguenze del populismo nelle grandi potenze economiche, poiché nei paesi piccoli o intermedi possono avere più o meno valenza, soprattutto nelle dinamiche interne del paese, mentre una politica populista degli USA può avere effetti molto più rilevanti. Ad esempio se la caratteristica principale dovesse essere un protezionismo estremo, o American first, si creerebbe un effetto domino o a catena su moltissime altre Nazioni; si verrebbero a formare conflitti determinati dal venir meno di un grande partner, abituato ad assorbire le esportazioni di tanti paesi. Ci sono fenomeni a livello mondiale che stanno insorgendo, come Erdogan Presidente della Turchia, Modi Presidente in India, Imran Khan primo Ministro in Pakistan, così come in Indonesia, Malesia e Tailandia, non pensiamo siano fenomeni solamente europei come Austria, Spagna, Francia con Marine Le Pen, Danimarca e la conosciuta Brexit, e chiaramente Italia. Questi fenomeni vanno studiati, vanno analizzati. Bisogna capire qual è il mal di pancia comune tra tutte le Nazioni che ho sopracitato; esiste sicuramente un fattore comune che determina questa trasformazione che è in atto, da questo cambiamento ci saranno delle conseguenze che noi esperti in Economia Politica siamo chiamati a interpretare e prevedere. Il tema di cui mi occupo come ricercatore, da circa una decina di anni è la teoria dei conflitti.
Nota: potete trovare un approfondimento su questo link: https://www.knowledge.unibocconi.it/notizia.php?idArt=17727
V: Dopo 22 anni passati negli USA rientrando in Italia quali sono state le sue prime impressioni?
M: Dall’America, sono tornato a Milano, quindi non ho risentito molto del passaggio, anche se mi è chiaro che ci sono realtà diverse e situazioni più difficili sul territorio nazionale. Pensando però alla sua domanda, mi viene istintivamente da riflettere, su quel giorno che da studente sono partito per l’America e il mio ritorno in Italia da Professore. Ho ben chiare queste due immagini, separate da un lasso di tempo abbastanza lungo, trovo un cambiamento enorme tra quel giorno che iniziai una nuova avventura in America, e adesso che sono tornato da professore. Oggi la Bocconi è una Università internazionale con studenti provenienti da tutto il mondo. La prima cosa che mi viene in mente è che all’interno dell’Università si parla in Inglese come normale linguaggio di comunicazione; questo cambiamento lo reputo un’ottima evoluzione. La mobilità a Milano è migliorata tantissimo: sintesi vocali su tram, autobus, metro.
Avevo 13 anni nel ’78 quando ho perso la vista e per 14 anni, fino al ’92, non ho mai usato il bastone bianco, per difficoltà psicologiche. Cercavo di dissimulare la cecità, avevo gli occhiali neri alla Stevie Wonder. Questo freno psicologico tra l’altro è scomparso improvvisamente e deliberatamente quando sono arrivato in America. In ogni caso è difficile valutare obiettivamente, dopo 22 anni. Ci sono stati cambiamenti radicali della città, ma non solo; anch’io come persona sono cambiato molto.
V: Matematica. Lei è vincitore di un progetto sulla matematica, ERC (European Research Council) advanced. Solo 3 italiani lo hanno vinto. La matematica è una componente fondamentale nei suoi studi accademici e sappiamo delle numerose difficoltà che gli studenti incontrano; vediamo come le ha risolte. Su questa tematica ho delle sottodomande….
V, 1: Come sono organizzate le università americane?
M: In America si usava la coordinazione dei centri simili al libro parlato. Quando sono partito, in Italia il libro parlato non era organizzato ma distribuito in maniera frammentata su tutto il territorio senza una coordinazione Nazionale, gli studenti richiedevano un testo e il LP lo preparava senza coordinazione fra le varie strutture e senza un piano di studi adeguato, ovvero non c’era mai nulla di disponibile a meno che non fosse stato richiesto da uno studente. In America invece c’era una organizzazione che si chiamava Recording for the blind & dislexic (RFB&D) mentre adesso si chiama Learning Ally di Princeton, una organizzazione molto grande; ogni qualvolta che uno studente richiedeva un libro loro fornivano un lettore e un assistente che controllava mentre il lettore leggeva, e interrompeva ogni volta che la lettura non veniva fatta bene, quindi un prodotto di alta qualità.
La matematica non veniva trattata diversamente dalle altre materie, sceglievamo dei volontari che ci aiutavano. Nell’audioteca erano presenti più di 100000 testi e trovavo molti testi di utilità per lo studio mentre quelli che non erano presenti li facevo fare. Aspettando che il libro arrivasse avevo una disponibilità di 5000 dollari all’anno da spendere per farmi leggere i testi da altri studenti, questa era una borsa di studio annuale, dedicata a studenti con disabilità visiva. Il PC l’ho iniziato ad usare nel ’93 al secondo anno di dottorato ad Harvard, il primo anno tutto su audiocassette e con lettura diretta con un assistente pagato con questa borsa di studio dedicata; all’Università del Michigan avevano molte sale computer, in poco tempo la hi technolgy è cresciuta e ha invaso gli Atenei Americani. Adesso con il computer è tutto più facile, troviamo tutto lì.
V, 2: Come legge e scrive testi contenenti formule?
M: Lì dovevo trovare un assistente bravo quindi tutto a voce e poi dovevo fissare concetti e formule ordinandole, ma soprattutto configurandole mentalmente. Adesso si è passati dalle cassette ai libri digitalizzati e con un software dedicato tipo Daisy, si può interagire facilmente con il testo, apponendo marker oppure saltando da un paragrafo all’altro velocemente. Attualmente il software giapponese Infty, trasforma il pdf in un file di testo. Se il testo matematico è troppo complicato, o le formule sono difficili, solo con l’audio non si riesce ad interagire bene, allora mi aiuto con la barra Braille. Personalmente io lavoro al 99% con file audio, sono abituato così. La sera, se leggo un articolo senza formule faccio fatica a rimanere sveglio, la matematica mi aiuta a rimanere concentrato.
V, 3: Ha mai usato LaTeX per scrivere documenti contenenti formule?
M: Sì, lo uso abitualmente.
V, 4: Per la statistica usa BrailleR [su libero scritto da Jonathan Godfrey della Massey University (Nuova Zelanda)]?
M: Lo conosco di nome, ma sinceramente io non mi occupo molto di statistiche, il mio lavoro è più improntato sul profilo organizzativo, o l’aspetto matematico teorico. Adesso le tecnologie sono andate avanti e parecchi studenti usano Excel molto bene: io non avendolo imparato quando ero studente mi dedico ad altro, ogni tanto entro in qualche tabella Excel, ma mi ci perdo dentro.
V, 5: Come accede a/redige grafici?
M: I grafici alcuni li facciamo direttamente con LaTeX, altrimenti vengono fatti da un assistente.
V: Quando ha finito il suo percorso formativo quali erano le sue prospettive, le sono arrivate offerte e proposte di lavoro, o pensava già alla carriera di ricercatore e di Professore?
M: Nell’89 quando ho scelto di andare in America prima del dottorato la mia intenzione era di occuparmi di mercati finanziari e di andare a lavorare in una azienda, mentre ero lì ho cambiato idea e mi sono appassionato agli studi di teoria economica, lì ho conosciuto Valiant, un esperto di microeconomia, mi disse che c’era un non vedente spagnolo ad Harvard University Boston, che studiava microeconomia. Quello è stato un punto di svolta nella mia vita.
V: Non ha mai pensato ad un’altra possibilità lavorativa ovvero tornando indietro farebbe un’altra strada o altro percorso formativo?
M: Nella mia famiglia sono tutti imprenditori, ho una buona percezione di cosa significhi questa professione, la mia prima idea era quella di percorrere la stessa strada. Un’altra idea che avevo in testa, partecipare ad una organizzazione per progetti di sviluppo di tecnologie o agricoltura o un’organizzazione dedicata alla sostenibilità dell’ambiente o altri campi, non so come avrei potuto acquisire sufficienti competenze e conoscenze per poterlo fare. Faccio notare che i bivi della vita, dove uno si trova a dover scegliere, esistono anche sulle materie di studio infatti io scelsi l’Università Bocconi solo perché aveva un pensionato attaccato all’università stile Campus all’Americana e per me era molto più facile orientarmi e muovermi senza difficoltà, ma soprattutto perché volevo un minimo di indipendenza. Credo che la passione per la ricerca sarebbe nata anche in altri ambiti Universitari, come ad esempio in agraria penso sia possibile, per una persona con disabilità visiva, un lavoro d’ufficio e ricerca. Se una persona con disabilità visiva si specializza in Scienze Sociali, forse è un po’ più facile, sono lavori d’ufficio e si viaggia meno. Mi sono specializzato in scienze economiche e discipline economiche sociali alla Bocconi, la passione per la ricerca probabilmente sarebbe nata anche in altri ambiti. Ho fatto un colloquio con Mc Kinsey & Company, Società internazionale di consulenza,
una loro domanda per l’assunzione era come potevo risolvere i problemi della mobilità e logistica. Alla Mc Kinsey non mi hanno assunto, forse avevano ragione loro.
V: In ambito lavorativo e della sua formazione quali sono state le sue difficoltà?
M: Credo il primo periodo che mi sono trovato ad insegnare, avevo difficoltà a comprendere e saper come guidare l’attenzione di una classe, per un Professore, non c’è mezzo migliore di comunicare con gli studenti avendo una lavagna e un gesso in mano, capire di aver catturato l’attenzione degli studenti è fondamentale. Ho avuto bisogno di un po’ di tempo ma sono problemi risolvibili, adesso con i lucidi si ovvia alla lavagna così come con i PowerPoint, nel complesso non mi ricordo di avere avuto un problema serio. Mentre qualche problema l’ho avuto quando ho finito il primo livello di formazione e ho provato a cercare consensi nelle persone che conoscevo, un professore famoso di Roma mi suggerì di non fare la carriera accademica, ma eventualmente di andare ad insegnare in qualche liceo, anche il Prof. Monti, mio relatore nell’esame di laurea, mi suggerì di andare a lavorare come ricercatore alla Comit.
Al presidente UICI di Milano chiesi cosa potevo fare, lui mi rispose: “Ma cosa vai a fare all’Università, quando finisci, andrai a guadagnare un paio di cento mila lire in più di un centralinista”, feci altre domande su mie problematiche ed interessi, rimasi senza alcuna risposta. Da quel giorno non ho messo più piede all’UICI di Milano, so che sono cambiate tante cose e mi sono ripromesso di tornare. Una cosa voglio sottolineare, che ho avuto sempre il sostegno e supporto da parte dei miei genitori; un ostacolo, potrebbero essere proprio i genitori che accudiscono in maniera troppo protettiva i figli.
V: Una domanda cattiva, non è mai entrato in competizione con un collega che provava a scavalcarla, usando, come minus, la sua disabilità visiva?
M: In Italia prima di partire per gli USA, avevo questa sensazione, non tanto verso le persone, ma verso l’intera disponibilità del sistema che ritenevo molto bassa. Infatti quando feci il colloquio con Mc Kinsey di Milano, non mi fecero l’offerta di lavoro e magari uno dei motivi era proprio perché non ci vedevo, può darsi che la loro idea sia stata che un non vedente, non potesse fare consulenze, leggere bilanci e documenti velocemente. Nell’ambito della ricerca, sia al dipartimento Europeo che in America, parecchi anni dopo, mi è stato riferito che non sono stato ammesso a dottorati particolari perché avevano paura che
non avrei potuto gestire e reggere lo stress del dottorato, quando me lo hanno riferito si sono resi conto che a quel tempo c’erano ancora molti pregiudizi e spero che dopo il mio passaggio abbiano capito che avevano sbagliato.
V: Potrebbe dare un consiglio ad un giovane disabile visivo, cosa gli indicherebbe o consiglierebbe di studiare?
M: Il consiglio non lo vorrei dare in base al vedere o meno, vorrei considerare esclusivamente quello che è il mercato del lavoro, indicherei le Hi-Technology come possibilità come informatica e le biotecnologie. Insomma noi dobbiamo usare la logica deduttiva nelle materie scientifiche, non dobbiamo farci condizionare dai laboratori, perché quello è solo un passaggio.
V: Approfitto subito del suo ruolo e le chiedo, può darmi un consiglio o una idea per una attività lavorativa da suggerire ai nostri ragazzi?
M: È una bellissima domanda ma su due piedi non riesco a dare una risposta, devo rifletterci sopra ma le giro un po’ la domanda, un invito che mi sento di suggerire è quello di perseguire anche nel tempo libero, ovvero al di fuori di un lavoro o studio, un linguaggio di programmazione come Python, o lingue come il cinese, l’Arabo o russo, in pratica impegnate del tempo per investire su voi stessi. Una conoscenza o formazione che nel tempo libero possa migliorare il livello o qualità della vostra vita in un prossimo futuro. Quindi magari accettare anche un lavoro come il centralinista, ma non fermatevi lì.
V: Insomma ricapitolando o dando un titolo al suo messaggio, formazione e va dove ti porta il cuore!
M: Sì, proprio così, ma mi rendo conto che la domanda che mi ha fatto è molto importante e tecnica, devo pensarci sopra sperando di trovare delle reali possibilità.
V: Come occupa il suo tempo libero?
M: Mi piace molto la musica Jazz, avevo molte soddisfazioni chiaramente in America, a Milano meno, ma mi diverto ugualmente. Pratico per il mio benessere e per il mio piacere molto sport, per tenermi in forma e come si dice “mens sana in corpore sano”.
Nota: Per quanto riguarda lo sport, il Professore si sofferma a lungo: su questa tematica scriverò un secondo articolo.
V: Può mandare un messaggio ai nostri ragazzi?
M: Davanti ai problemi non bisogna assolutamente scoraggiarsi, ma perseguire il proprio obiettivo. Secondo un mio personale calcolo bisogna investire mediamente duemila ore di lavoro prima di dire o meno se si è in grado di saper fare qualsiasi cosa, prima non ti è permesso di dire che non sei capace o non hai talento. Vorrei che passasse il messaggio che il talento conta molto meno, rispetto la volontà di perseguire un obiettivo, ma è necessario molto impegno e costanza.